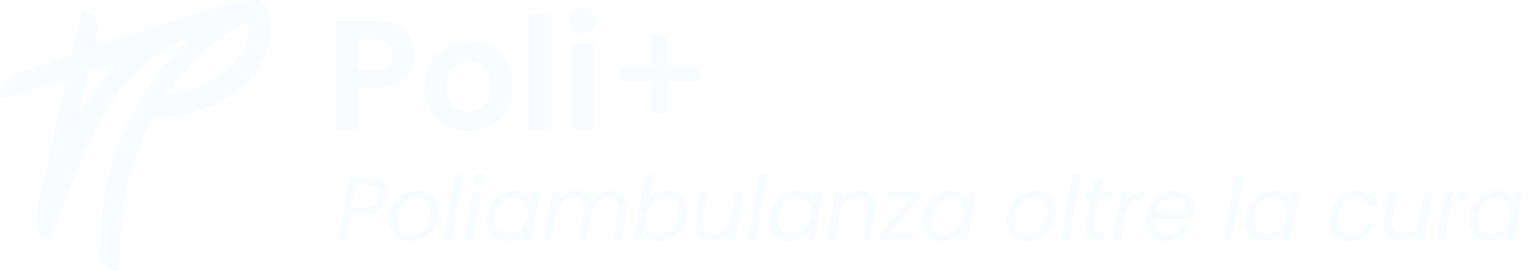C’è un luogo, all’interno di Poliambulanza, in cui le domande più difficili non vengono evitate, ma accolte. Sono le domande che nascono dove la medicina incontra il suo limite: davanti alla sofferenza, al dubbio, al morire. Quel luogo è il Board bioetico, un piccolo gruppo di esperti che da più di dieci anni accompagna la riflessione etica all’interno dell’ospedale. Un team silenzioso ma fondamentale, che lavora su ciò che non si può prescrivere con una ricetta e che non trova risposte nella scienza.

«Il Board bioetico lavora su questioni che nascono all’interno della pratica clinica di Poliambulanza», racconta don Maurizio Chiodi, teologo e coordinatore del comitato. «È un piccolo gruppo composto da figure provenienti da diversi ambiti — medici, filosofi, giuristi, bioeticisti, infermieri — che si incontrano per riflettere insieme su dilemmi reali, posti da chi cura e da chi è curato».
I confronti all’interno del Board nascono sempre da un’esperienza concreta: un dubbio posto da un medico, un’infermiera, un paziente.
«Si parte da una storia, perché — sottolinea Chiodi — non esistono “casi clinici”, ma persone, vicende uniche, a volte dolorose, spesso complesse».
A partire da quelle storie, il gruppo costruisce un percorso di riflessione strutturato, che tiene insieme l’analisi clinica e quella etica, i riferimenti del Magistero cattolico e la pluralità delle visioni culturali presenti nella società.
«Poliambulanza è una fondazione di ispirazione cristiana, ma questo non significa chiusura confessionale. L’orizzonte cristiano diventa una possibilità per parlare un linguaggio accessibile a chiunque sia in ricerca del bene, della verità, anche in una società segnata dal pluralismo etico, culturale e religioso».
Il Board, dunque, non si limita ad applicare norme o codici deontologici, ma cerca di illuminare le zone grigie della pratica sanitaria. Le sue conclusioni non sono “verità calate dall’alto”, bensì proposte di discernimento, pensate per accompagnare le decisioni di medici, infermieri, pazienti e famiglie.
Il dilemma del fine vita
Uno degli ambiti in cui il Board è stato più sollecitato è quello del fine vita. In un recente lavoro, partito da un confronto con una decina di medici della struttura, sono state raccolte sette storie cliniche particolarmente significative. Storie rese anonime, ma cariche di domande universali.
Parlare di fine vita oggi significa, prima di tutto, riconoscere una rimozione collettiva. «Viviamo come se non dovessimo mai morire», osserva Don Maurizio Chiodi.
«La nostra società, nella sua corsa verso l’efficienza e il benessere, tende a ignorare la morte. Non ne parla, la nasconde. E questo rende molto più difficile affrontarla, soprattutto quando arriva dentro un ospedale».
È su questo sfondo culturale che il Board bioetico è chiamato a riflettere. Perché la morte non è solo un evento medico, ma un’esperienza profondamente umana, carica di significati simbolici, religiosi, emotivi. E oggi, proprio perché spesso rimossa, la morte arriva come uno spaesamento. Non solo per chi la vive, ma anche per chi accompagna: i medici, gli infermieri, i familiari. «È difficile parlarne», ammette Chiodi. «Eppure proprio lì, davanti al limite e al “senso”, emergono le domande vere».
Nel documento redatto dal Board a partire dalle sette storie, quelle domande si sono fatte più nitide.
«Abbiamo individuato alcuni nodi che ritornano spesso e su quelli abbiamo sviluppato le nostre riflessioni».
Il primo riguarda la pluralità degli sguardi coinvolti. Una scelta sanitaria non nasce mai in solitudine. Anche se la responsabilità ultima è del paziente, nel necessario dialogo con il medico, intorno ci sono sempre altre figure: infermieri, psicologi, familiari. Ognuno porta un frammento di verità, una sensibilità, un’esperienza. Curare, allora, non è solo un atto tecnico, ma un’opera collettiva, fatta di dialogo, confronto, ascolto reciproco.
Un altro nodo decisivo è la centralità della storia del paziente. In ospedale si parla spesso di “casi”, ma Chiodi insiste: nessuna persona può essere ridotta a un caso clinico. Anche se la diagnosi è la stessa, ogni storia è diversa: diverso il modo in cui la malattia è vissuta, diversa la rete affettiva, diverse le esperienze etiche e culturali che hanno accompagnata la persona in tutta la vita. «Curare, allora, significa entrare in quella storia, comprenderne la trama, accoglierne anche le fragilità».
Su questo terreno si colloca anche una visione dell’autonomia del paziente che rifiuta tanto l’individualismo quanto il paternalismo.
«Non è più tempo — dice Chiodi — né di medici che decidono “al posto di”, né di pazienti lasciati da soli davanti a scelte enormi. Il Board propone un’autonomia relazionale, fondata sul dialogo: il paziente resta il protagonista delle sue scelte, ma accompagnato, sostenuto, dentro una rete di relazioni significative. La decisione è personale, ma mai solitaria».
E quando si parla di scelte, torna un altro tema centrale: il dire la verità. Non basta informare. Non si tratta solo di comunicare una diagnosi o spiegare una prognosi. Dire la verità è un gesto che implica attenzione, empatia, rispetto.
La verità non può essere separata dalla relazione. Va detta nel momento giusto, nel modo giusto, tenendo conto di chi si ha di fronte. «La verità — ricorda Chiodi — non deve travolgere, ma accompagnare». Anche la legge lo riconosce: il tempo della comunicazione è un tempo di cura.
In questo paesaggio complesso, il Board invita a coltivare una virtù antica e necessaria: la saggezza. Perché in molte situazioni non c’è una soluzione netta, non si tratta di scegliere tra il bene e il male, ma tra possibilità imperfette, saper cogliere le sfumature del bene possibile. La saggezza è quella capacità di discernimento che tiene conto della persona, del contesto, della proporzionalità tra benefici e sofferenze. «È il coraggio di scegliere il bene possibile, non quello ideale, ma quello concreto, in quel momento».
Proporzionalità è un’altra parola chiave. «Una cura è proporzionata quando offre più benefici che danni, quando preserva la dignità, quando mantiene viva la possibilità di relazione. Quando dà tempo, ma anche qualità al tempo». E in quel “giusto mezzo” — mai facile da trovare — si gioca gran parte dell’etica della cura.
E poi c’è un’altra verità che attraversa tutte queste riflessioni: nessuno è davvero solo. Anche nelle decisioni più personali, anche nella morte. Le scelte individuali si intrecciano con quelle della comunità: i familiari, il personale sanitario, la società intera.
«Lo si è visto con chiarezza durante la pandemia, quando le risorse erano limitate e le decisioni tragiche. Ma è una consapevolezza che dovrebbe restare, anche fuori dall’emergenza: ogni scelta di cura è anche una scelta di comunità».